Il monastero
Alla fine del Medioevo a Roma era assai diffuso il fenomeno religioso delle “case sante”, piccole comunità spontanee di bizzoche e terziarie, che conducevano una vita austera, povera e casta, fatta di lavoro manuale, di preghiera, di condivisione dell’altrui sofferenza. La differenza di questo tipo di vita rispetto al monachesimo femminile tradizionale era radicale, per la semplicità dell’organizzazione comunitaria, per la libertà di vincoli gerarchici di subordinazione, per l’assenza di formalismo. Queste comunità aperte erano sul piano organizzativo delle realtà con caratteristiche del tutto nuove, autogestite, ricche di una autonomia e flessibilità sconosciuta alle antiche fondazioni monastiche e profondamente radicate nel mondo cittadino, dove si rendevano presenti con la loro opera di carità e di assistenza. L’esperienza delle oblate di Tor de’ Specchi affondava le sue radici in questo complesso e variegato tessuto di devozionalità femminile, ma furono la forte personalità di Francesca Ponziani e il suo eccezionale carisma a rendere Tor de’ Specchi un caso unico. Rispetto ad altre istituzioni locali, che si sarebbero presto estinte, la fondatrice pose infatti le condizioni dello sviluppo e della continuità plurisecolare di una casa che si sarebbe inserita in profondità nel contesto cittadino. Il progetto religioso di Francesca era originale e innovativo, perché cercava di conciliare l’essenza degli ideali monastici con i valori della spiritualità laicale: le oblate non erano del mondo, ma vivevano nel mondo e nella storia, attraverso la carità e il servizio attivo a favore del prossimo.
L’oblazione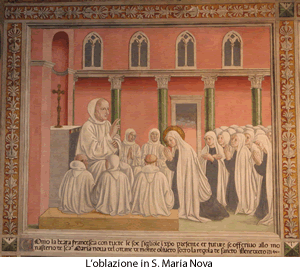
Il 15 agosto 1425, nella solennità dell’Assunzione, dieci donne, guidate da Francesca, si offrirono come oblate della Vergine nella basilica di S. Maria Nova al Palatino, retta dai monaci olivetani. Il piccolo gruppo delle compagne era costituito da esponenti delle famiglie più ricche e facoltose della nuova nobiltà cittadina, ma soprattutto legate alla nuova borghesia degli affari e dei commerci. Pur continuando a vivere nelle proprie case, esse si impegnavano, con l’oblazione, a una vita cristiana più perfetta, nella frequenza sacramentale, nelle penitenze, nelle opere di carità.
La regola
La svolta decisiva si ebbe però nel 1433, quando venne affittata una piccola casa nel rione Campitelli presso la chiesa di S. Andrea dei Funari. L’abitazione sorgeva all’ombra della Torre degli Specchi e le oblate vi si ritirarono il 25 marzo, festa dell’Annunciazione, data di inizio della vita in comune. Il trasferimento era stato preparato e meditato a 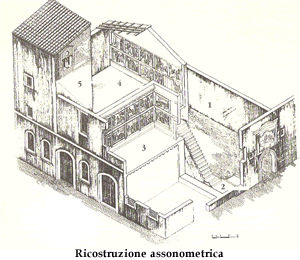 lungo. Nel corso di alcune estasi, Francesca, su ispirazione della Vergine e dei tre santi protettori della nuova congregazione – san Paolo, san Benedetto e Maria Maddalena -, aveva dettato alcune essenziali regole di vita largamente ispirate alla misura e alla sobrietà dello stile benedettino, nella pratica del sonno e dell’alimentazione, nella preghiera e nel lavoro manuale. Il criterio cui doveva ispirarsi la disciplina delle oblate era l’ordine, la via media, da perseguire nella modestia, nella povertà personale, nell’obbedienza al volere della presidente. L’umiltà e l’equilibrio avrebbero evitato pericolose devianze: è la grande intuizione della legislazione benedettina. In una visione del 1432, proprio alla vigilia della fondazione, viene fatto un preciso riferimento alla metafora classica della vita monastica, quella dell’alveare. Le sorelle devono prendere esempio dalle api, simbolo di vita industriosa e organizzata, che cercano un luogo dove poter dare frutto e riunire la famiglia. Ognuna di loro ha la propria cella e un compito preciso. Vivranno del loro lavoro, senza lasciare l’alveare, perché potrebbero incontrare molti pericoli, perire e non godere dei frutti della loro fatica. Le visioni di Francesca rappresentano la regola carismatica e informale di Tor de’ Specchi, e a questo insegnamento le oblate si sono sempre mantenute fedeli nel corso dei secoli.
lungo. Nel corso di alcune estasi, Francesca, su ispirazione della Vergine e dei tre santi protettori della nuova congregazione – san Paolo, san Benedetto e Maria Maddalena -, aveva dettato alcune essenziali regole di vita largamente ispirate alla misura e alla sobrietà dello stile benedettino, nella pratica del sonno e dell’alimentazione, nella preghiera e nel lavoro manuale. Il criterio cui doveva ispirarsi la disciplina delle oblate era l’ordine, la via media, da perseguire nella modestia, nella povertà personale, nell’obbedienza al volere della presidente. L’umiltà e l’equilibrio avrebbero evitato pericolose devianze: è la grande intuizione della legislazione benedettina. In una visione del 1432, proprio alla vigilia della fondazione, viene fatto un preciso riferimento alla metafora classica della vita monastica, quella dell’alveare. Le sorelle devono prendere esempio dalle api, simbolo di vita industriosa e organizzata, che cercano un luogo dove poter dare frutto e riunire la famiglia. Ognuna di loro ha la propria cella e un compito preciso. Vivranno del loro lavoro, senza lasciare l’alveare, perché potrebbero incontrare molti pericoli, perire e non godere dei frutti della loro fatica. Le visioni di Francesca rappresentano la regola carismatica e informale di Tor de’ Specchi, e a questo insegnamento le oblate si sono sempre mantenute fedeli nel corso dei secoli.

Il riconoscimento papale
Francesca affidò la cura della comunità a tre procuratori: il sacerdote Giovanni Mattiotti, l’olivetano Ippolito, il francescano Bartolomeo Bondi, figure in un certo senso speculari ai tre intercessori celesti della nuova congregazione. Il 4 luglio del 1433 papa Eugenio IV riconobbe ufficialmente l’istituto, concedendo alle oblate il diritto di possedere una casa, eleggersi una presidente, accogliere altre donne e scegliersi un confessore. Il 9 agosto 1439 venne anche l’approvazione dei monaci olivetani, mentre qualche mese dopo la morte di Francesca, nel 1440, l’abate generale fra Battista da Poggibonsi definì i rapporti giuridici tra l’ordine di Monte Oliveto e le suore, cui veniva concessa una larga autonomia anche riguardo all’accettazione delle nuove oblate. Rimaneva al priore di S. Maria Nova il diritto di ricevere l’oblazione e il dovere di dare alle suore una sepoltura onorevole nella basilica.
Il monastero aperto
Tor de’ Specchi era dal punto di vista istituzionale una realtà singolare e profondamente innovativa. Le oblate di Francesca non erano né monache né laiche. Sotto il profilo del diritto canonico erano secolari, rimanevano cioè nel loro stato e non erano vincolate a voti pubblici. La loro promessa aveva un valore personale e per questo a 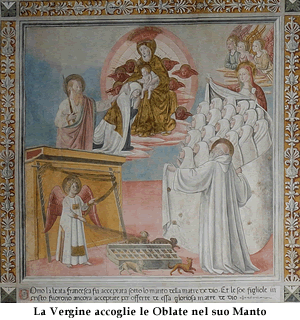 differenza delle monache tradizionali non erano vincolate alla clausura. Nelle intenzioni di Francesca Tor de’ Specchi doveva rimanere un monastero aperto, in grado di mantenere un rapporto vivo con il mondo circostante, mentre esistevano precise norme canoniche che vietavano la vita in comune delle terziarie.
differenza delle monache tradizionali non erano vincolate alla clausura. Nelle intenzioni di Francesca Tor de’ Specchi doveva rimanere un monastero aperto, in grado di mantenere un rapporto vivo con il mondo circostante, mentre esistevano precise norme canoniche che vietavano la vita in comune delle terziarie.
Il progetto della fondatrice era dunque in anticipo sui tempi, anche se esso esprimeva esigenze profonde del movimento religioso femminile del Quattrocento, indipendentemente dalla famiglia di afferenza. Basti pensare al caso coevo delle suore della beata Angelina da Montegiove, bizzoche anch’esse, che in quegli stessi anni attuarono la loro piccola rivoluzione a Foligno cercando di dar vita a una nuova congregazione di terziarie francescane regolari.
Ottenuta l’approvazione della Sede Apostolica, definite le relazioni con la congregazione di Monte Oliveto, quando Francesca morì, nel 1440, poteva guardare con serenità all’avvenire della sua piccola comunità, certa anche della protezione particolare della Vergine.
Età barocca
Agli inizi del Cinquecento, un censimento degli istituti femminili romani redatto alla vigilia del Sacco (1527) annoverava ormai Tor de’ Specchi tra i monasteri più importanti della città, con presenze superiori alle quaranta unità. Se l’evento tragico dell’occupazione di Roma da parte dei lanzichenecchi ebbe conseguenze assai serie sulla vita di molti istituti femminili, che erano stati uno degli obiettivi privilegiati della violenza dei soldati, la casa del Teatro di Marcello venne protetta anche grazie al saggio governo della sua presidente Lucrezia Ponziani.
Ma il secolo d’oro di Tor de’ Specchi fu il Seicento, quando la comunità arrivò a contare fino a 138 oblate. La lista delle suore nel Libro delle memorie permette di ricostruire la fisionomia di un ben caratterizzato matronage aristocratico che comprendeva tutte le famiglie romane di nobiltà antica o più recente: Orsini, Colonna, Del Drago, Cenci, Capizucchi, Lancellotti, Serlupi, Accoramboni, Massimi, Del Bufalo, Cesi, Pamphili. Le esigenze di una comunità in piena espansione e l’entusiasmo per la canonizzazione di Francesca nel 1608 si tradussero anche in un nuovo fervore costruttivo. Sino ad allora le oblate avevano abitato un piccolo agglomerato di modeste case medioevali attigue alla Torre degli Specchi, che costituivano quasi una sorta di quartiere nell’isolato. Il bisogno di nuovi spazi e le necessità di una ordinata vita regolare determinarono l’edificazione di un vera e propria fabbrica conventuale che inglobò in maniera omogenea le diverse unità abitative. Fu nella prima metà del Seicento che il monastero assunse gradualmente l’aspetto che conserva tuttora, con la chiesa di S. Maria de Curte acquisita nel 1594, la cappella barocca dell’Annunziata, il grande chiostro attribuito al Maderno, la sagrestia ultimata nel 1657.
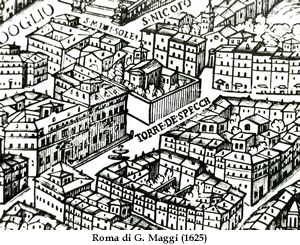
Le “cittadine” oblate
Un momento particolarmente difficile nella storia ormai plurisecolare di Tor de’ Specchi si ebbe nell’ultimo quarto dell’Ottocento, in relazione alle leggi di soppressione degli enti religiosi e di incameramento dei beni ecclesiastici emanate dal Governo italiano sin dal 1855 ed estese a Roma nel 1873. Inizialmente, anche Tor de’ Specchi venne spogliata di tutti i suoi beni dalla Giunta liquidatrice, ma il ricorso della madre presidente Maria Luisa Canonici venne accolto e definitivamente confermato dalla Cassazione, proprio in relazione al peculiare statuto giuridico di un istituto che nel tempo aveva mantenuto i suoi caratteri originari di libera e spontanea associazione religiosa. Lo stesso Cavour in Parlamento prese le difese delle “cittadine” oblate, che non avendo voti solenni né privilegi come gli altri ordini religiosi, pagavano le tasse regolarmente e dunque non dovevano essere toccate.
Soltanto nel 1958 l’oblazione, per decreto di papa Giovanni XXIII, assunse il valore giuridico di voti semplici, pubblici e perpetui che non implicavano la clausura. Questa svolta si era resa possibile, senza che si snaturasse la fisionomia peculiare di Tor de’ Specchi, dal momento che il Codice di diritto canonico del 1917 aveva finalmente riconosciuto le Congregazioni religiose di voti semplici.


